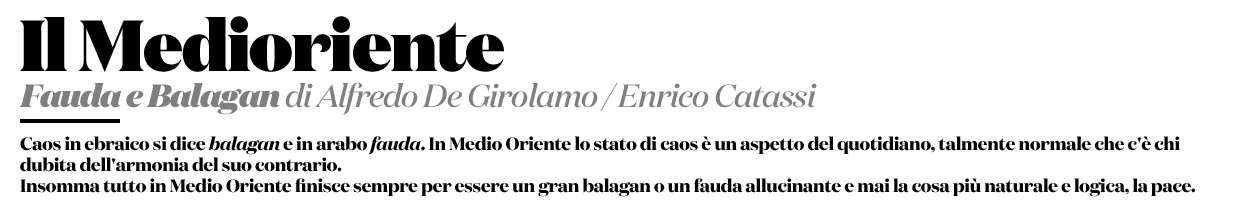Israele è un paese in tilt, e la ragione non è solo la guerra, che non è comunque un corollario. Il caos imperante è attribuibile a una classe politica che, pur eletta democraticamente, si sapeva aprioristicamente avrebbe potuto deragliare, trascinando la nazione in un condensato di tensione e attesa. È il fallimento attestato e drammatico di un governo tutt’altro che all’altezza del compito affidato: non ha garantito la sicurezza dei propri cittadini, non ha mantenuto la tenuta sociale, ha invece puntato a smantellare il patto “costituzionale” vigente. Di questa crisi è parte integrante Benjamin Netanyahu, principe machiavellico pluri indagato che ha saturato “l’ambiente” con una narrativa inadeguata, una prospettiva infelice e una pessima gestione del potere. Culminata nella mancata liberazione degli ostaggi. Come spiega su Haaretz Noa Landau: “Netanyahu cerca di presentare alla sua base politica una scioccante equazione populista: o un accordo per liberare gli ostaggi e porre fine alla guerra, o la sicurezza di tutti gli altri cittadini israeliani. Come primo ministro deve prendere la strada maestra: sacrificare gli ostaggi per un bene immaginario più grande. Questa, tuttavia, è un’equazione completamente falsa… l’uomo che ha costruito, esaltato e reclamizzato il marchio di ‘Mr. Sicurezza’ per tutta la sua carriera politica, con costanza esemplare, ha in realtà ottenuto l’esatto contrario”. Viceversa, la disgrazia per i palestinesi si chiama Hamas. Che non rispetta nessuna regola “civile”, ma non può essere annientata totalmente con le armi. Sconfitta invece sì. Ed in parte militarmente è stato fatto, in questi mesi, al costo di migliaia di civili palestinesi e centinaia di soldati israeliani. Dissente dalla strategia in atto Yitzhak Brik, generale riservista: “Se continuiamo a combattere a Gaza penetrando e compiendo raid sempre sugli stessi obiettivi, non solo non porteremo Hamas al collasso, ma crolliamo noi stessi. Non molto lontano da oggi non saremo in grado di effettuare questi ripetuti attacchi, perché ogni giorno che passa le Forze di Difesa Israeliane si indeboliscono e il numero di morti e feriti in azione tra i nostri soldati aumenta. Hamas, al contrario, ha già riempito i suoi ranghi con ragazzi di 17 e 18 anni”.
La realtà di Israele è nella fotografia di un giorno qualunque: nella notte di domenica una marea umana è scesa in strada a Tel Aviv, chiedendo la liberazione degli ostaggi. La mattina seguente alla protesta si è aggiunto lo sciopero generale, indetto dal sindacato Histadrut e poi revocato dal tribunale. Intanto, l’estrema destra inscenava la sua contromanifestazione a Gerusalemme, accusando la federazione dei lavoratori di incoraggiare il terrorismo, stessa linea che adotterà anche Netanayhu nel corso della giornata. Contemporaneamente fuori dall’ufficio di reclutamento dell’esercito a Tel Hashomer decine di giovani religiosi ultraortodossi protestavano per il diritto all’esenzione dalla leva obbligatoria. Mentre a Gaza si sparava e al confine con il Libano sistematicamente risuonano le sirene di allarme missilistico. Infine, il partecipato e commovente funerale di Hersh Goldberg-Polin. Lacrime e scuse, portate dal presidente Isaac Herzog: “a nome dello Stato di Israele, per non essere riusciti a proteggervi nel terribile disastro del 7 ottobre, per non essere riusciti a riportarvi a casa sani e salvi”. Persino Netanyahu nell’appello televisivo serale chiede perdono, ma non torna indietro sulla trattativa. Fuori dal coro, e come al solito inappropriate, le parole del ministro Itamar Ben-Gvir che non si vergogna a dire pubblicamente di fare tutto ciò che è in suo potere per impedire il negoziato.
Israele è divisa in spicchi: il fronte degli anti-Bibi e pro tregua è in crescente ebollizione. La fazione dei filo-Bibi e per tenere ad oltranza i piedi a Gaza è guardinga. La porzione dei dogmatici, coloro che osservano la fede, prima della legge, viaggia invece in un mondo chiuso. Mentre, la quarta fetta o componente di Israele, gli arabi, è silente e teme di essere isolata ancora di più. Uscire da questo labirinto senza la frantumazione è oggettivamente il vero problema da dirimere. A trainare la pacificazione sociale non basta il dolore per le vittime e nemmeno la guerra a Gaza, forse una guerra su larga scala potrebbe cambiare lo stato d’animo generale. Sicuramente in questo contesto non può essere fatto affidamento sul fattore economico, per tenere i rami della pianta ben saldi al tronco. La stima dei costi dell’attuale conflitto è tra 50 e 70 miliardi di dollari. Il ministero della difesa prevede che occorrano investimenti di circa altri 6 miliardi. Nel 2024 il giudizio del rating finanziario dei mercati non è stato positivo. Lo shekel ha perso potere d’acquisto. Il deficit in estate è balzato all’8,1%. Il settore del turismo (3% del PIL) è evaporato. Last but not least, il fatto che a presentare la legge di bilancio è il ministro di estrema destra Bezalel Smotrich, poco avvezzo alle oscillazioni del paniere ma diligente nello spostare risorse verso gli insediamenti in Cisgiordania, anche a quelli illegali per la legge israeliana.
Del tutto improbabile che la riconciliazione interna avvenga su ispirazione del procuratore generale Gali Baharav-Miara. Le sue raccomandazioni, compresa quella dell’istituzione di una commissione d’inchiesta sui fatti del 7 ottobre e sui presunti crimini di guerra compiuti a Gaza, sono state immancabilmente respinte dal governo. Che non la vuole ascoltare, pensando di rimuoverla.
E allora appena ci sarà la tregua militare, l’unica soluzione praticabile è il ritorno al voto, con l’incognita del risultato. Perchè se vincesse Bibi vi sentirete ripetere: “Questa è la democrazia”.